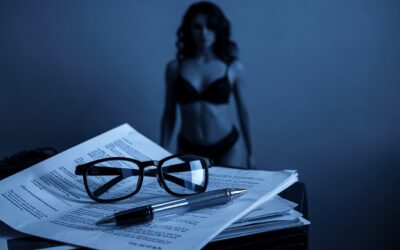La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13858 del 9 aprile 2025 stabilisce un principio fondamentale per i professionisti contabili: il commercialista che conosce l’esistenza di una contabilità “in nero” tenuta dalla società cliente successivamente fallita, ma non la denuncia, non risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Suprema Corte ha annullato la condanna inflitta nei gradi di merito, tracciando un confine netto tra conoscenza e concorso nel reato.
Il caso e la decisione della cassazione
Il caso riguarda un consulente contabile di una Srl a gestione familiare dichiarata fallita. Nei gradi di merito, il professionista era stato ritenuto responsabile di concorso in bancarotta fraudolenta documentale per non aver denunciato la contabilità in nero della società cliente. La Cassazione ha ribaltato questa impostazione con una motivazione che chiarisce i confini delle responsabilità professionali.
Gli ermellini hanno precisato che la mera conoscenza della gestione personalistica che i soci facevano della cassa sociale non costituisce presupposto sufficiente per configurare un obbligo di segnalazione o denuncia alle autorità giudiziarie. Il commercialista, in quanto consulente esterno, non aveva alcun dovere giuridico di attivazione in tal senso.
Gli elementi probatori determinanti nell’assoluzione
Determinanti nell’analisi della Corte sono stati diversi elementi probatori emersi nel procedimento. In primo luogo, non esisteva alcuna prova che il professionista avesse costruito inganni o alterato artificiosamente la contabilità ufficiale. Al contrario, era stato dimostrato che il commercialista comunicava regolarmente ai soci tutte le imposte da pagare sulla base della contabilità ufficiale da lui tenuta, l’unica di cui aveva effettiva conoscenza.
Un altro elemento rilevante riguarda i bilanci societari: nessun bilancio della cliente era mai stato approvato dai soci. Questo fatto ha ulteriormente escluso l’ipotesi di un concorso del professionista nella tenuta della contabilità parallela “in nero”, che veniva invece gestita internamente alla società e utilizzata dai soci per giustificare gli ammanchi di cassa.
La distinzione tra consulenza e gestione societaria
La sentenza traccia una linea di demarcazione netta tra l’attività di consulenza contabile e la gestione operativa della società. Il Tribunale di primo grado aveva già escluso la responsabilità del commercialista anche per bancarotta impropria e preferenziale, riconoscendo che le decisioni su quali fornitori pagare in via prioritaria attengono “strettamente alla fase operativa e gestionale, che rimanda a decisioni dirette ed esclusive dei membri della famiglia”.
Questo principio riveste particolare importanza per tutti i professionisti contabili: la consulenza tecnica si distingue nettamente dall’amministrazione aziendale. Le scelte gestionali rimangono di esclusiva competenza degli organi societari, senza che il consulente esterno possa essere chiamato a risponderne, salvo un concorso attivo nel reato.
Le condotte di distrazione e dissipazione: chiarimenti giuridici
La Corte ha colto l’occasione per fornire importanti precisazioni sulle condotte che integrano il reato di bancarotta fraudolenta. La “distrazione” consiste nel distacco dal patrimonio sociale di beni ai quali viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori. Tale condotta è penalmente rilevante indipendentemente dallo stato di insolvenza dell’impresa al momento del fatto.
La “dissipazione”, invece, si configura quando i beni vengono impiegati in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale. Si tratta di scelte consapevolmente incongrue rispetto alle effettive esigenze aziendali, valutate considerando dimensioni e complessità dell’impresa, oltre alle specifiche condizioni economiche e imprenditoriali esistenti.
Il confine tra bancarotta semplice e fraudolenta
Un ulteriore aspetto chiarito dalla sentenza riguarda la distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta nelle operazioni rischiose. La Cassazione richiama un principio consolidato: la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti configura il delitto di bancarotta semplice quando tali operazioni si inquadrano comunque nell’interesse dell’impresa.
Si configura invece la bancarotta fraudolenta quando l’agente persegue dolosamente un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa. L’elemento discriminante diventa quindi la finalità dell’operazione: se orientata, pur in modo rischioso, al beneficio aziendale si avrà bancarotta semplice; se volta a favorire interessi personali o di terzi, si configurerà la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta.
Implicazioni pratiche per i professionisti contabili
Questa pronuncia ha rilevanti implicazioni pratiche per tutti i commercialisti e consulenti contabili. Se da un lato viene confermato che il professionista non ha un obbligo generalizzato di denuncia della contabilità irregolare di cui venga a conoscenza, dall’altro rimane fermo il principio che il consulente non deve contribuire attivamente a operazioni di falsificazione documentale.
Il commercialista deve mantenere la propria indipendenza e correttezza professionale, astenendosi dal partecipare a condotte fraudolente. In un caso pratico, si pensi al professionista che venga a conoscenza di prelievi non contabilizzati da parte dei soci: se si limita a tenere correttamente la contabilità ufficiale, segnalando ai clienti gli obblighi fiscali, non risponderà penalmente per le irregolarità commesse autonomamente dalla società.